cult
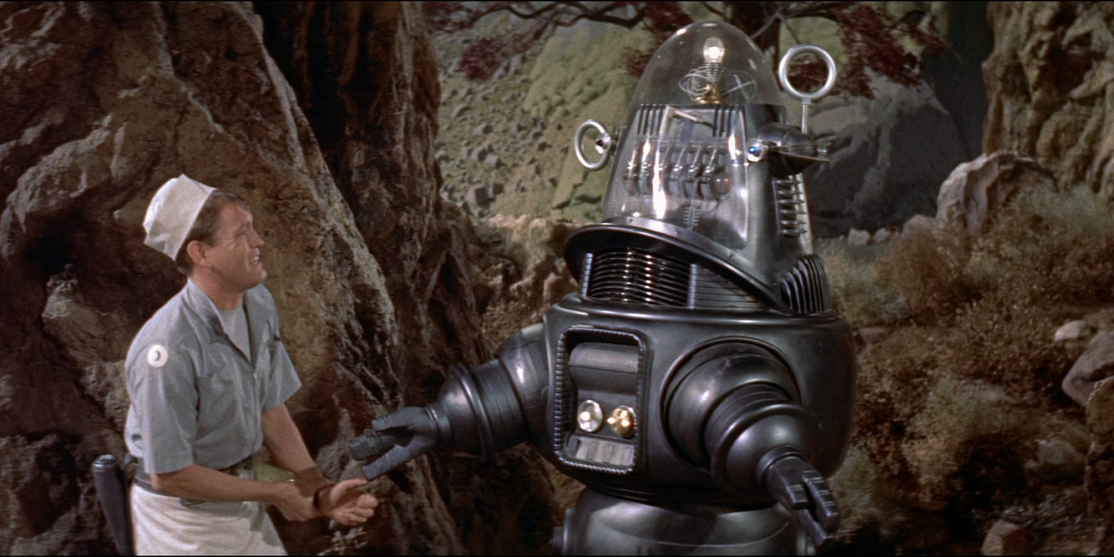
CULT
L’automa che dunque sono
Ciò che nelle nostre vite appare vivo, spontaneo e libero è spesso effetto di forme di automatismo che agiscono al di sotto della soglia cosciente e che determinano parte dei nostri comportamenti. In “Filosofia dell’automatismo” Igor Pelgreffi propone un originale percorso di riflessione teorica sulle nozioni di automaton, abitudine e habitus, in vista di un “apprendimento critico” dei nostri automatismi che possa aiutarci a tracciare i contorni di una nuova etica della corporeità
Più analizziamo la nostra vita, il nostro mondo sociale, perfino il nostro pensiero, più scopriamo che molto di ciò che appare vivo, spontaneo, libero è in realtà effetto di pratiche ripetitive, di schemi precostituiti, di meccanismi inconsapevoli. Qualcosa di affascinante e inquietante al tempo stesso sottopone il tema dell’automa alla vertigine del pensiero, un pensiero che cerca di scoprire il segreto della propria libertà ma che viene costantemente risospinto verso una zona d’ombra, un non-sapere, un punto cieco ove la sua autonomia pare irresistibilmente attratta e messa fuori corso dall’automatismo.
E se invece fosse proprio l’automatismo ciò che paradossalmente ci rende liberi? È questa la mossa tentata da Igor Pelgreffi nel suo recente volume Filosofia dell’automatismo. Verso un’etica della corporeità (Orthotes, 2018). Pelgreffi ci invita infatti a guardare attraverso il meccanismo che instaura l’automatismo per scoprirne qui, nel punto sorgivo, tanto le valenze oppressive ed alienanti, quanto l’infinita risorsa che lo anima e che rende possibili strategie critiche di “de-automatizzazione”.
 L’ambizioso ma stimolante lavoro di Pelgreffi muove da una definizione classica di automatismo risalente agli anni ‘30 per allargare subito il campo ai non-detti che sembrano strutturarla dall’interno. Il campo teorico in cui la nozione di automatismo emerge, infatti, appare costituito da tensioni e contraddizioni fondamentali: l’automatico ci si mostra come, al tempo stesso, ciò che arresta il flusso del vivente e ciò che, così facendo, gli dà forma e dunque conferisce senso e direzione al suo vivere. L’automatismo non è semplice ripetizione ma un “impulso a ripetersi” (p. 77) laddove decisivo è il nesso incredibilmente elusivo tra impulso, ripetizione e sé. C’è infatti un’ambiguità fondamentale nel termine stesso autòs: esso indica sia il sé, il movimento centripeto, il punto di sintesi assoluto attorno a cui si organizza il Selbst, quanto anche ciò che va da sé l’impulso improvviso, la spinta verso l’esterno, l’elemento di spontaneità irriducibile senza cui non potrebbe darsi alcun vivente.
L’ambizioso ma stimolante lavoro di Pelgreffi muove da una definizione classica di automatismo risalente agli anni ‘30 per allargare subito il campo ai non-detti che sembrano strutturarla dall’interno. Il campo teorico in cui la nozione di automatismo emerge, infatti, appare costituito da tensioni e contraddizioni fondamentali: l’automatico ci si mostra come, al tempo stesso, ciò che arresta il flusso del vivente e ciò che, così facendo, gli dà forma e dunque conferisce senso e direzione al suo vivere. L’automatismo non è semplice ripetizione ma un “impulso a ripetersi” (p. 77) laddove decisivo è il nesso incredibilmente elusivo tra impulso, ripetizione e sé. C’è infatti un’ambiguità fondamentale nel termine stesso autòs: esso indica sia il sé, il movimento centripeto, il punto di sintesi assoluto attorno a cui si organizza il Selbst, quanto anche ciò che va da sé l’impulso improvviso, la spinta verso l’esterno, l’elemento di spontaneità irriducibile senza cui non potrebbe darsi alcun vivente.
Guardato attentamente il problema dell’automatismo mette in causa e mobilita nozioni apparentemente rigide consegnateci dalla tradizione metafisica. Ad es. l’alternativa tra la sovranità e la spontaneità nella costruzione del soggetto, poiché non c’è soggettività senza auto-dominio, eppure senza un movimento di libera auto-affezione dell’io su sé stesso essa si ridurrebbe a morto meccanismo, l’io non avrebbe “vita”. Lo stesso dicasi per altre nozioni come le classiche distinzioni tra “prima” e “seconda” natura, tra “interno” ed “esterno”. Per ognuna di esse Pelgreffi mostra come l’automatismo si muova in una zona intermedia, istituisca o si generi all’interno della loro relazione disgiuntiva, e come questa zona abbia il proprio centro nella corporeità. Laddove infatti la tradizione spiritualistico-vitalista intende il problema dell’automatismo come un reificarsi della vita della coscienza, dell’attività del soggetto, qualcosa che avviene quando la ripetizione blocca il vissuto in una temporalità chiusa, meccanica, quantitativa rispetto alla quale si tratterebbe di riattivare l’istanza vitale-qualitativa (Bergson) o l’istante della decisione autentica (Heidegger), Pelgreffi suggerisce di spostare il focus sul piano della spazialità (si veda, ad es., come lo stesso nesso meccanico stimolo-risposta venga problematizzato nella fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty in quanto il dato empirico “esterno” non viene mai assunto passivamente dal corpo ma sempre anche attivamente costruito internamente: la percezione è forma-azione dell’input).
La strategia di Pelgreffi è dunque quella di accettare tutto ciò che negli sviluppi del pensiero contemporaneo decentra il soggetto rispetto a se stesso, spodestandolo dal ruolo di vertice o centro dell’esperienza e del pensiero, ma non per sottometterlo integralmente a ciechi automatismi, bensì mostrando come gli automatismi non siano affatto ciechi e come il soggetto emerga a partire da essi in quanto molto di ciò che attribuiamo al soggetto in termini di spontaneità, libertà, eticità, riflessività ecc. si trova già a livello del corpo e della sua capacità interna di gestione degli automatismi. Funzioni superiori come la memoria o il ragionamento ipotetico, osserva Pelgreffi, si trovano già sedimentate a livello dei meccanismi biologici (la “memoria cellulare” di Nietzsche, la struttura “se…allora” implicata nella teoria dei riflessi di Pavlov). Se noi siamo, in un certo senso, la sintesi dei nostri automatismi, ciò implica non solo, come osserva Deleuze, che tale sintesi è più antica della coscienza, che si dà cioè un “processo sintetico pre-umano” (p. 84), ma anche che essa, avvenendo nel corpo, non è solo il prodotto di un’attività ma anche di una passività sintetica.
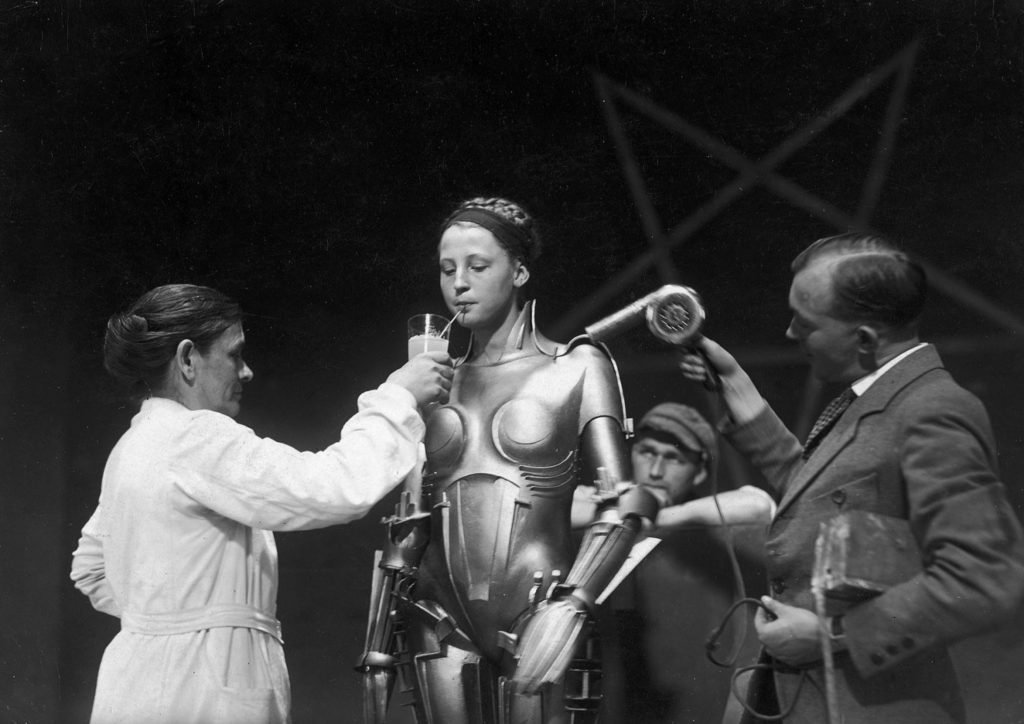
Proprio qui, dove l’originale e il simulacro si inseguono, il volontario e l’involontario si intrecciano, l’attività e la passività si confondono, sembra giocarsi la possibilità di leggere i temi dell’automatismo, dell’automatico, dell’automazione – e quelli contigui dell’abitudine, della ripetizione e della routine – non nel senso di una limitazione o soppressione della libertà, bensì, paradossalmente, nel senso di ciò che limita, sì, ma in tal modo dà forma alla libertà. Non nonostante ma grazie a e attraverso l’automatismo siamo o possiamo essere liberi. Si tratta di evidenziare il protagonismo del corpo in questi processi, il corpo come luogo in cui avviene l’adattamento ma anche un’incancellabile resistenza ad essi. Il corpo definisce cioè ciò che Pelgreffi chiama una “omeostasi teoretica” (p. 207) tra attività e passività. La tematica della corporeità, infatti, chiama in causa nozioni decisive come quelle di campo-ambiente o quella di relazione: non c’è corpo che non sia concresciuto e situato; non c’è corpo che non sia intessuto di relazioni ad altri corpi. Il corpo è il luogo in cui i nodi degli automatismi di ogni tipo vengono al pettine: è qui che il bios è attraversato strutturalmente dalla techne, il divenire ciò che sono è intriso di storicità (un processo per trial and error in cui differenza e ripetizione si coappartengono ab origine), il mio saper fare si modella nell’interazione con l’altro. Pelgreffi dedica pagine centrali del volume alla discussione del problema dell’intersoggettività e del rapporto con gli automatismi sociali, cercando di mostrare sia la centralità dell’habitus nella costruzione del carattere come dispositivo attivo/passivo di adattamento alla norma (Aristotele, Bourdieu), sia anche la centralità del rifiuto che possiamo e dobbiamo a volte opporre a questo adattamento: una rivolta che sorge non da un volontarismo o da una scelta razionale ma da un esaurirsi interno dell’automatismo (Camus) e che trova la propria radice nel fatto che il corpo oppone una resistenza ontologica ai meccanismi disciplinari (Foucault), poiché lo stesso installarsi del dispositivo sociale in noi non può avvenire che attraverso un contro-movimento che strutturalmente il corpo gli oppone nel momento in cui vi si adatta. Ed è a partire da questo duplice carattere “aperto” del corpo che, secondo Pelgreffi, emergono le opposte potenzialità del nostro modo di vivere ed essere vissuti dagli automatismi: da un lato, la passiva accettazione che può giungere sino al parossismo (auto)distruttivo della coazione a ripetere, dall’altra l’emergere di uno stile che è la quintessenza di un automatismo abitato secondo libertà.
Il corpo acquisisce infatti schemi di azione che configurano una sorta di “razionalità incarnata”. Ma questa acquisizione non può dirsi davvero riuscita se, al di là della ripetizione, non dà luogo ad una capacità di libera variazione e adattamento (sul modello dell’attore, dell’improvvisazione musicale, dell’attività dell’artigiano). Pelgreffi usa come metafora il bricolage, la capacità del soggetto di produrre un novum che altro non è se non riassemblaggio creativo e adattativo del già esistente. Proprio questa caratteristica dell’automatismo rende possibile i processi di de-automatizzazione e apre la strada ad una revisione critica dell’intero campo dell’automatismo, alla capacità di definire e praticare un’etica degli automatismi.

Pelgreffi sviluppa questo tornante decisivo del volume citando ciò che Bateson chiama “deutero-apprendimento”: apprendere ad apprendere (pp. 203 e sgg.). È così che la chiusura del libro, tracciando i prolegomeni ad un’etica della corporeità, in realtà affronta questioni teoriche vertiginose che investono l’essenza stessa della filosofia. Pensare l’automatismo nella sua genesi, infatti, non è mossa che possa compiersi dall’esterno, quasi che il pensiero non debba venire a sua volta coinvolto nella meccanica che vorrebbe descrivere. Non solo ogni pensiero si produce a partire da automatismi logici, psicologici e stilistici, ma l’essenza stessa del pensiero filosofico è, da sempre, una tecnica sui generis in cui è in gioco il volere se stessi in vista di sé stessi. Ed è esattamente la natura opaca, indeducibile e concreta del corpo a far sì che l’essenza del gesto filosofico non si riduca ad una vuota tautologia ma acquisti un contenuto. Il corpo è infatti ciò in cui quella volontà in un medesimo atto si condensa in sé stessa e si apre all’altro, si localizza e si temporalizza, acquista forma e capacità di movimento. La stessa possibilità di riflettere criticamente sugli automatismi di cui siamo intessuti, la riflessione critica in cui la filosofia pretende afferrare la propria origine e la propria destinazione, non sarebbe possibile senza questo riflesso irriflesso, questo impulso irriducibile che permette di identificarci solo laddove scopriamo che il nocciolo di ciò che siamo si sottrae al nostro sguardo perché da sempre, anche, lo costituisce.
