cult

CULT
Disfare e rifare le case. Le esperienze femministe dell’abitare #1
“Domesticità” di C. Cossutta, uscito per Edizioni ETS, ci insegna a dire cos’è la casa e come iniziare a comprendere come si producono i generi, chi è donna e chi è uomo; ci fa dire cos’è lavoro, intuire come si articolano le città: significa guardare la società tutta da una figurazione gravida di sensi
Il volume Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi del XIX secolo, scritto da Carlotta Cossutta e recentemente edito da ETS, è uno strumento femminista prezioso. Un testo che ci serve per guardare lo spazio del domestico al contempo da lontano e da vicino.
Da lontano: Cossutta ci permette di rintracciare nel passato diversi tentativi femminili, se non esplicitamente femministi, di riscrivere lo spazio dell’abitare oltre i vincoli dell’architettura dominante e dell’ingegneria sociale.
Da vicino: Carlotta ci consente di muoverci lungo la linea del tempo, così che i quesiti sulla dimensione-casa, che ci poniamo qui e ora, come femministe occidentali del XXI secolo, si riarticolino intrecciandosi a storie, sperimentazioni e immaginari emersi dalla riflessione e dall’incontro tra donne in altri tempi e altri dove.
Leggo Cossutta a pochi anni dalla quarantena Covid, quando la casa ci si è stretta addosso. Leggo Cossutta da ricercatrice precaria che, nello spazio altrettanto precario dei “suoi” appartamenti, trasloco dopo trasloco, ha letto e scritto un quantitativo innumerabile di parole, soffrendo la solitudine e la distanza di un nuovo tipo dilavoro beffardamente “meritevole” dell’appellativo smart.
Leggo Cossutta mentre riconosco fino a che punto queste sensazioni si sono inscritte nel tessuto di un corpomente – il mio – che è archivio politico, aperto alle influenze degli spazi abitati e prodotti da una Storia di cui sono prima rendering, poi vera e propria materializzazione, riverberandola nel quotidiano e nel vissuto.
Leggo Cossutta da Milano e dai suoi dintorni, il territorio dei canoni d’affitto inarrivabili con uno stipendio medio-basso e mai garantito a lungo termine. La leggo da un qui che è la costosissima città che ha sintetizzato il suo carattere attrattivo, vitale e dinamico dalla combinazione tra comunicazione friendly e sussunzione dei tentativi di fare comunità altrimenti: la leggo dalla Milano in cui i progetti di co-housing rivolti a quelle persone e community (sic!) che abbiamo imparato a chiamare hipster o radical chic occupano più tempo, più spazi, più attenzione politica di quanto non facciano le partite sociali giocate sul terreno delle case popolari (Tozzi, 2023). Leggo Cossutta da una geografia in cui i cambiamenti dei rapporti tra reddito e lavoro a vantaggio della rendita di capitale – ossia, frutto di risparmi investiti in beni immobili – trasformano in chimere le soluzioni abitative che ci consentono di arrivare a fine mese, che non siano troppo lontane dagli affetti e che possano in qualche modo ristorarci, ossia rappresentare un sito di cura – salvo quando queste mura spesso abitate come unic* membr* del nostro nucleo familiare non si fanno troppo spesse, e salvo il fatto che questa cura è ciò che quotidianamente (e faticosamente) non dobbiamo dimenticare di restituire a noi stess* nel gorgo delle scadenze e di una precarietà economico-esistenziale che non fa sconti in materia di tempo (Lorey, 2015).
Leggo Cossutta, e ci scrivo attorno, mentre abito il “mio” ennesimo appartamento e abito una precarietà che diventa forma efficace e violenta di regolazione dell’esistente, scandendo e producendo il presente e i soggetti, sfumando a proprio vantaggio gli spazi del privato, del professionale e del pubblico gli uni dentro gli altri.
Scrivo mentre il mercato degli affitti a lungo termine è deformato sempre più favorevolmente per i proprietari dal processo di airbnbizzazione della città (Gainsforth, 2020).
E scrivo queste parole mentre il DDL sicurezza minaccia ulteriormente le pratiche squatter e le occupazioni a mezzo repressione. Scrivo questa recensione perché abitare stanca (Gainsforth, 2022)e perché nuove forme dell’abitare sono urgenti e necessarie.
Preludio n. 1
Grazie alla sezione Donne con la cinepresa dell’edizione 2023 del Pordenone film festival, ho potuto vedere un girato, quasi dimenticato, del 1978, in cui s’indagano i rapporti tra corpi femminili e domesticità in una dimensione del sociale “squisitamente” fordista: è Donne da slegare, diretto da Armenia Balducci, Maria Paola Maino e Marilisa Trombella. L’escamotage del voice-over in post-produzione ha permesso a Chiara Ingrao, Margherita Repetto e Sandra Sassaroli di commentare la giornata tipo di una casalinga italiana di cui non sentiamo mai la voce, limitandoci a vederla mentre si affaccenda tra le più comuni mansioni del lavoro domestico: cucina, pulisce i fornelli, rassetta il letto, stira camicie, ripone i prodotti appena acquistati nella dispensa.
Ripresa dalla camera negli spazi-tempi della sua quotidianità a ripetere, ne vediamo il corpo ricurvo sull’asse da stiro e sul piano cucina, ne cogliamo i movimenti in un succedersi di stanze e corridoi che non lasciano spazio al movimento inedito, ma disegnano percorsi e tragitti prevedibili, quasi inevitabili, in una geografia personale&politica già prescritta da un’architettura votata alla minimizzazione dello sforzo, avendo come obiettivo non tanto il di lei beneficio, quanto la massimizzazione della sua performance.
Le tre voci delle femministe in voice-over – donne di cui, invece, non vediamo i corpi – commentano le espressioni sul volto della casalinga, imbastendo una critica ragionevole, ma al contempo di carattere coloniale, alla violenza del lavoro domestico, descrivendo da lontano un corpo afono ed esposto a uno sguardo autoptico, seppur sia uno sguardo di donna.
Preludio n. 2
Carla Lonzi in Armande sono io! dice: «…le case sono ancora uno dei pochi luoghi non indecenti, dove la qualità del vivere è mantenuta grazie a una donna che s’impone. Se anche le case fossero in mano agli uomini ci sarebbe una degradazione sicura, peggio della bomba atomica per l’avvenire dell’umanità» (Lonzi 1992, p. 18). Si tratta – paradossalmente? – della stessa Lonzi che, nel Manifesto del 1970, scritto con le altre donne di Rivolta Femminile, ribadisce di voler sfatare il mito della laboriosità sussidiaria della donna, e dunque di identificare «nel lavoro domestico non retribuito la prestazione che permette al capitalismo, privato e di stato, di sussistere» (Lonzi e Rivolta Femminile [1970] 2010, p. 8). In questo orizzonte critico, la casa si rivela per Rivolta Femminile e Lonzi come vera e propria anticamera della fabbrica, parte di un continuum spazio-temporale prodotto – ma, al contempo, occultato – dalla ratio capitalistica, col supporto di quella patriarcale, per massimizzare i profitti, pagando solo il lavoro svolto fuori dal privato delle mura domestiche.

Ritorno al presente
Se dovessi definire in un solo gesto il mio rapporto con la casa, direi che è un rapporto femminista, e che questo criterio d’intellegibilità politico sostanzia questo spazio dinnanzi ai miei occhi come un luogo di contestazione. Figlia di una casalinga, osservo le analisi sul lavoro domestico e sul design delle abitazioni cercando di stare a contatto con quello che mi è stato, e mi è, possibile cogliere dell’esperienza di mia madre, operaia della casa —definizione, quest’ultima, proposta nei Settanta dal femminismo marxista dei Gruppi per il Salario al lavoro domestico, per evidenziare il carattere produttivo, ossia votato alla produzione di plusvalore, del lavoro delle donne.Ma osservo la casa, altresì, riconoscendovici lo spirito così ben raccontato dalla Carla Lonzi della dignità insita nel fare casa per stare a contatto con la bellezza nelle spaziotemporalità del quotidiano.
Il mio rapporto con la casa è femminista anche in altri modi, più esplicitamente militanti: la frequentazione di collettivi politici, squat e centri sociali – misti e separati, in Italia e altrove – mi ha resa riluttante a pensare al mio futuro in quel tipo di dimensione abitativa che, pressoché tutt* nell’Occidente del capitalismo avanzato, abbiamo ricevuto in eredità.
Desidero piuttosto la sperimentazione di quelle che con Valeria Graziano amo chiamare condotte non-domesticate in ambienti che vengono tradizionalmente fatti coincidere con «un’altra istituzione, quella della famiglia e del familiare, entità omogenetiche – ovvero produttrici di uniformità – per eccellenza» (Graziano 2020, p. 144).
Eppure, mentre cerco di fuggire dalla trappola della replica del contesto abitativo che mi ha formata, divento sempre più cosciente del fatto di avere un’allergia per quelle soluzioni alternative e comunitarie che sono le «piccole comuni utopiche e felici dalle quali verrebbe immediatamente voglia di scappare» (ivi., p. 146).
Come riuscire a trovare alternative alla domesticità mainstream? In cui non solo la cura non sia un lavoro sulle spalle di poche, come nel caso di mia madre e di tutte le altre donne come lei, ma in cui la vita collettiva sia una risposta al contempo per bisogni e desideri? In cui la condivisione di intenti, spazi, investimenti, risorse materiali e responsabilità non diventi una stretta soffocante e vincolante? In cui la dicotomia tra privato e comune non si trasformi in vampirizzazione dell’individuo? Ma piuttosto serva davvero a ripensare la vita nell’interdipendenza oltre la dicotomia tra personale e politico e senza la riduzione dell’uno nell’altro? Da Cossutta imparo a considerare le forme della casa come punto di osservazione privilegiato per analizzare i complicati processi da cui dipendono quegli spazi di soggettivazione sempre contingenti che sono i siti del nostro abitare. Da Domesticità di Cossutta imparo a cogliere questi spazi dentro i rapporti sociali da cui emergono e che, in un vero e proprio circuito ri/produttivo, irrobustiscono di ritorno. In questo orizzonte, dire cos’è la casa e come si struttura significa iniziare a comprendere come si producono i generi, chi è donna e chi è uomo; significa dire cos’è lavoro, intuire come si articolano le città: significa guardare la società tutta da una figurazione gravida di sensi.
Il libro Domesticità permette di dotarsi di parole, concetti e pensieri insoliti senza pretendere di offrire scorci su esperienze impeccabili, rilevando pedissequamente i punti di forza e quelli di debolezza di pratiche sperimentali da re-inscriversi in una genealogia femminista capace di fare della casa un terreno per la prefigurazione di mondi nuovi e più giusti.
Cossutta sostiene che «osservare cosa succede dentro e intorno alle case […] permette di guardare con occhio critico alla storiografia che vede nel XIX secolo solo la centralità del movimento che rivendica l’emancipazione attraverso il suffragio per mettere in luce, invece, come in quel periodo sia in corso una battaglia più ampia che chiama in causa tutti gli aspetti della vita» (Cossutta 2023, p. 15). In altre parole, Cossutta rileva il fatto che, già nell’Ottocento, le donne, e specificatamente le femministe, sapevano che le forme classiche della politica, ossia quelle del voto e della deliberazione – disegnate dagli uomini per un mondo al maschile – non riuscivano a cogliere i più carsici processi di trasformazione biopolitica dei corpi e del sociale a mezzo di strumenti materiali e spazi atti a orientare individui e collettività nel contatto su base quotidiana, come veri e propri minuti artigiani della soggettività. In particolare, lo sforzo di ripensare l’architettura, così come l’urbanistica – o in termini più generali, le pratiche dell’abitare –, era già nel XIX secolo recepito come una sfida verso nuove comunità, soprattutto dalla prospettiva situata e sessuata della riproduzione.

Considerare la riproduzione come una prospettiva politica – ovvero come vero e proprio paradigma d’intellegibilità (Giardini e Simone, 2015) – significa far contare il rapporto privilegiato tra donne e spazio dell’abitare come leva per la rigenerazione della vita umana (intesa in termini biologici, tanto quanto culturali) e analizzare un certo sistema dal suo ground zero, cercando di muovere in direzione del miglioramento delle relazioni tra generazioni, del soddisfacimento dei bisogni complessi, della tutela della bellezza come elemento indispensabile per il buon vivere, dell’introduzione e dello sviluppo di tecnologie capaci di ridisegnare gesti e rapporti.
Se, in effetti, alcune delle autrici incontrate mano nella mano con Cossutta si sono limitate a ipotizzare interventi di fatto riformisti, tesi solo a collettivizzare il lavoro domestico tra donne – pagando loro un salario, magari; liberandole dall’isolamento, certamente; e dunque socializzando la riproduzione oltre la famiglia nucleare – senza far saltare la dicotomia tra funzioni sociali del femminile e funzioni sociali del maschile, altre si spingono verso forme di sovversione dei rapporti sociali tra generi proprio attraverso la riscrittura del domestico.
Tra le prime ricordiamo certamente Catherine Beecher, Melusina Fay Peirce e Charlotte Perkins Gilman. Beecher, per esempio, insiste sull’importanza di considerare le mansioni delle casalinghe come un vero e proprio lavoro, evidenziandone le componenti cognitive complesse, come la scelta del tipo di tessuto migliore per confezionare diversi indumenti, quella delle migliori strategie chimiche per pulire macchie di natura differente oppure preparare pasti nutrizionalmente equilibrati per le esigenze dei vari membri della famiglia.
Tuttavia, pur rilevando le vere e proprie conoscenze scientifiche del lavoro domestico, Beecher non si spinge a prefigurare la sovversione del ruolo della donna nella società patriarcale, rimarcando anzi i confini dei suoi tratti squisitamente morali rispetto a quelli degli uomini, insistendo per esempio, sul ruolo materno nella diffusione di valori civici lasciati essenzialmente invariati, semplicemente sfumati, o meglio ri-equilibrati, da quelli conquistati nello spazio femminile della casa e della cucina.
Case senza cucina
Anche Melusina Fay Peirce muove in maniera scomposta tra intuizioni impoteranti e ritorno alle norme istituite e istituenti. La sua ostinazione sulla partita della liberazione del tempo delle donne, ispirandosi al socialismo utopico premarxista, la conduce a proporre una gestione cooperativa dello spazio domestico e una conseguente rimodulazione del suo design. Peirce immagina strutture composte da 24 alloggi che avrebbero condiviso una cucina e una lavanderia all’avanguardia. Le tecnologie occupano un posto di rilievo in questa proposta: conoscendo e attraversando quotidianamente la città industriale, Peirce poteva rilevare la sistematica arretratezza delle tecnologie riproduttive dinanzi all’implementazione di sempre aggiornate tecnologie produttive. Seppur alcune macchine per l’impasto e la lavorazione del pane e le prime lavatrici erano già state inventate ai suoi tempi, l’organizzazione monofamiliare delle abitazioni – e, dunque, quella della riproduzione attorno al lavoro della singola madre/moglie – rendeva oneroso, se non impossibile, l’acquisto di questi nuovi mezzi potenzialmente cruciali per ridurre il tempo dedicato alla riproduzione e conseguentemente liberare le donne da giornate di lavoro in casa senza limite orario.
Peirce non vedeva quello che oggi è chiaro alle femministe, ossia che i problemi legati all’introduzione di nuove tecnologie nel campo del lavoro di cura non si esauriscono al costo elevato dei dispositivi o alla condivisione degli stessi: spesso, infatti, migliorare la prestazione riproduttiva e ridurre i tempi della cura ha determinato il (paradossale?) innalzamento degli standard alimentari, igienici o relazionali, spostando sempre più in là i canoni e i criteri cui aderire come lavoratrici della casa.
L’immissione di nuove tecnologie nel campo del lavoro riproduttivo delle donne non era pensata, tuttavia, da Peirce come mero addendum a una società rimasta invariata: infatti il ruolo della famiglia nucleare veniva messo in crisi dall’immissione di certe tecnologie condivise, andando a cambiare la perimetratura di spazi e funzioni, spingendo soprattutto verso uno slittamento dalla proprietà e dall’uso privati di mezzi e spazi a una proprietà e uso condivisi dalla comunità oltre la coppia. Ma anche qui il lavoro domestico resterà una prerogativa femminile, e, tra le donne, nella gestione cooperativa di Peirce, alcune saranno sovrintendenti ai lavori mentre altre operative de facto nelle mansioni più dure. Se questa divisione del lavoro interna al genere si premurava di rispondere alla partita aperta dalla questione del rendimento e dell’organizzazione efficace di un lavoro riproduttivo inedito e collettivizzato, essa andava altresì a ricreare gerarchie forti di classe.
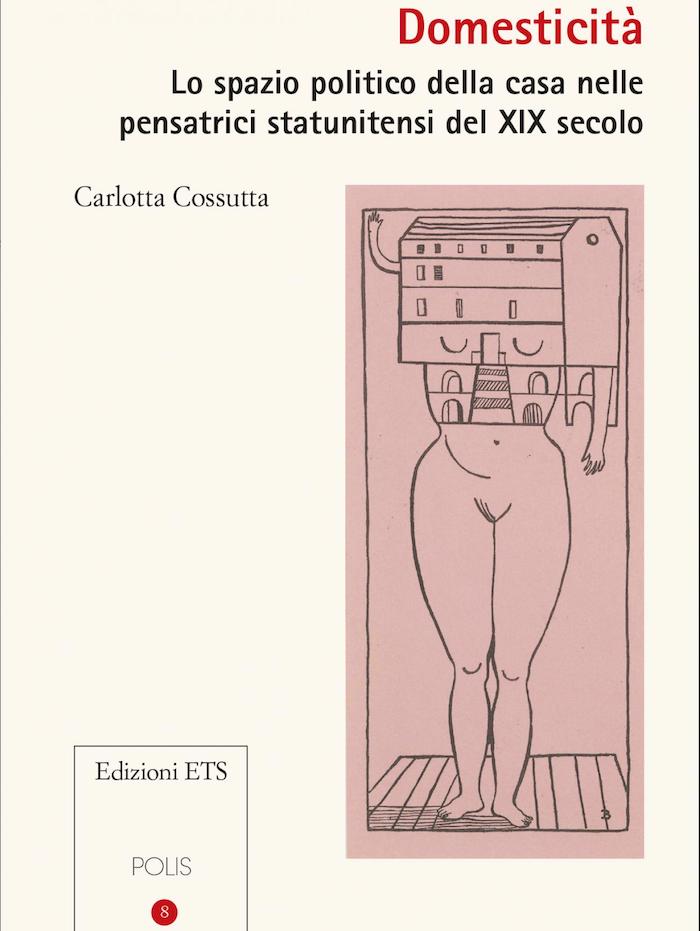
La cucina condivisa da 24 gruppi familiari nel progetto cooperativo di Peirce inaugura la tradizione entusiasmante della casa senza cucina. La seguirono, ci dice Cossutta, Marie Howland, Charlotte Perkins Gilman e Alice Constance Austin. Perkins Gilman, autrice, tra gli altri testi, di Women and Economics, insiste in modo esplicito sulla casa senza cucina, inserendosi nel filone della collettivizzazione del domestico. Questa autrice insiste, soprattutto, sulla necessità di formare in modo professionalizzante tutte le persone da impiegare nel lavoro di cura, dalla cucina all’allevamento e educazione de* bambin*, prevedendo una remunerazione per le figure incaricate da gestori della comunità, dunque, senza che l’intermediazione con le professioniste fosse lasciata alla singola famiglia, o a piccoli gruppi di famiglie.
Se, come ci dice Cossutta, «la condizione di vita delle donne e il loro lavoro» sono «strettamente legati non solo a forme dell’abitare, ma anche alla possibilità di immaginare società future, in cui la famiglia nucleare perde la sua centralità rispetto al lavoro riproduttivo, in favore di forme sociali che permettono di costruire una società non fondata sulle singole famiglie ma sulla cooperazione in senso più generale», Perkins Gilman riesce a intuire la partita della destituzione della famiglia nucleare come pilastro economico e sociale delle comunità umane.
Ma, sempre come Cossutta nota, la sfida non è condotta fino in fondo neppure da lei se si considera che i ruoli di cura, pur pagati e gestiti cooperativisticamente, sarebbero stati comunque prerogativa delle donne. Del resto, il passaggio dal fordismo al postfordismo a partire dai Settanta, e poi nel corso degli Ottanta del Novecento, ci permette di vedere più da vicino come un salario per il lavoro riproduttivo contrattualizzato non lede in sé e per sé le grammatiche patriarcali che vedono le donne sempre al posto delle donne, in cucina o appresso ai bambini, oppure ancora impiegate nel settore dei servizi con il pubblico come commesse oppure hostess, a ricoprire di nuovo il ruolo di governanti delle emozioni e della gestione delle risposte affettive del soggetto che riceve un certo servizio (Hochshild, 1983). Se ne sono rese conto le lesbiche dei Gruppi per il Salario al lavoro domestico negli USA, denunciando una vera e propria tendenza estenuante alla cura, sviluppatasi in secoli di disciplinamento delle donne tutte a mezzo di un’educazione influenzata dalle esigenze della divisione sessuale del lavoro come matrice necessaria dell’accumulazione. Anche le donne lesbiche, dunque, – fuggite alla convivenza con quel male breadwinner da cui dipendere senza soluzione di continuità nelle partiture della famiglia patriarcale – si ritrovavano “impantanate” nell’assoluzione al ruolo di ancelle sorridenti e pazienti del capitale, come cameriere o cassiere accondiscendenti e sempre ben disposte all’interazione (Wages Due to Lesbians, 1975).
*****
Nel prosieguo di questa recensione si affonderà nel vivo di esperienze comunitarie, passate e presenti, capaci di mettere in luce esigenze e desideri per un vivere e un abitare altrimenti.
Foto di copertina di Caterina Latorre Canet, su WIkimedia commons
SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS
Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno
