approfondimenti

EUROPA
Digital Service Act, la battaglia europea sulla regolamentazione delle piattaforme
Le norme in discussione del Dsa e del Dma sembrano andare a intaccare il modello di business della piattaforme digitale, tanto che alcuni le definiscono “rivoluzionarie”. Ma è davvero così?
Una regola non scritta dice che quando c’è tanto, troppo consenso, quando i giudizi sono pressoché unanimi, forse andrebbe alzata la “soglia critica”. Se poi i commenti entusiasti vanno da quelli di Thierry Breton, sì proprio l’ex ministro delle finanze parigino di Sarkozy e ora commissario europeo per il mercato interno – che per l’occasione adotta nientemeno che un linguaggio antimonopolista – fino a quelli di esponenti della sinistra, i sospetti dovrebbero crescere. Tanto più se dentro quei commenti ci sono le parole “rivoluzione” e “digitale”. In questo caso, tutto suggerirebbe di stare davvero molto attenti.
Quei due termini infatti riempiono, straripano da quasi tutte le riflessioni che accompagnano il varo del Digital Markets Act e del Digital Services Act (Dma & Dsa).
Quasi varo: perché i testi di questi due megaimpianti legislativi che dovrebbero ri-regolamentare l’intero universo digitale sono stati presentati dopo un estenuante iter legislativo: vagliati prima dalla Commissione europea, poi nelle commissioni competenti e dall’aula del parlamento di Bruxelles, che li ha messi ai voti. Ma non è finita: perché la fase decisiva comincia ora, nella cosiddetta – con un’orrenda espressione – “trilogia”, cioè nelle trattative a tre, fra commissione, una delegazione del Parlamento e i singoli governi nazionali. Sì, il vecchio continente legifera così, con queste procedure elefantiache.
La macchina burocratica
I tempi? Stavolta, a differenza di quanto è sempre avvenuto davanti a norme complesse, non saranno però sterminati. Perché l’attuale presidenza parigina ha già fatto capire che vuole la loro approvazione definitiva entro l’estate, in modo che Macron se la possa “vendere” nelle ormai imminenti elezioni francesi.
Due testi non ancora definitivi, dunque. Due testi – il primo che vorrebbe scrivere regole per pratiche commerciali “corrette”, il secondo più rivolto agli utenti – che sono pieni di rimandi uno all’altro, che non possono essere esaminati singolarmente. Ma ha senso parlarne adesso, anche in mancanza del sì definitivo, perché il risultato ultimo difficilmente si discosterà da quel che è stato votato e se lo farà, lo farà in peggio. Come è sempre avvenuto.
E che le lobby delle Big Tech siano già al lavoro per condizionare ancora di più le norme, lo raccontano mille episodi, mille denunce. Dagli incontri negli uffici di Bruxelles richiesti da Microsoft e non resocontati, ai documenti ufficiali di tutti i grandi gruppi del settore.
Tentativi ai quali le associazioni per i diritti digitali – perché non dirlo? associazioni sempre più istituzionali – si “oppongono”, chiedendo solo di poter assistere alle trattative.
Le Big Tech vogliono condizionare ancora di più le norme. Forse è questa l’espressione giusta: perché in realtà – checché se ne dica e scriva – le due volumetriche architetture legislative, per molti, tanti aspetti si tengono sulle generali. Si fermano a dichiarazioni di intenti, camminando sospese fra due diverse concezioni dei diritti digitali. Ed è facile immaginare come nella fase applicativa basti una piccola spinta per farli pendere dalla parte dei colossi.
A cominciare dal Digital Markets Act. Anche qui i commenti parlano del primo tentativo di creare un “mercato equo e competitivo”. Limitando – parole di un po’ tutti i commissari – lo strapotere della GAFAM, Google, FaceBook, Microsoft, Meta, Apple, Amazon e via dicendo.
Sarebbe assurdo negare che questo in parte avviene. I giganti – nei testi vengono chiamati “gatekeeper”, definizione che include tutto, comprese le compagnie dell’audiovisivo, dello streaming ed i colossi del web – dovranno sottostare a diverse regole: non potranno comprimere la concorrenza, non potranno vendere prodotti con applicazioni preinstallate.
E ancora: i social, a cominciare da FaceBook, dovranno spiegare come e quanto moderano le discussioni nelle loro pagine, quanto personale impiegano in questo lavoro, dovranno fornire un report annuale per dettagliare cosa e quanto fanno nel contrastare le violenze contro le minoranze.
Regole che, se non rispettate, potranno essere punite con multe fino al dieci per cento del loro fatturato. E stavolta a occuparsene dovrebbe essere direttamente l’Europa: Bruxelles, non il tribunale di Dublino, dove hanno sede tutte le Big Tech, da sempre considerato un porto delle nebbie. Che non è mai riuscito a concludere un’indagine.
E in più – cosa sulla carta rilevantissima – le nuove norme imporrebbero la fine della profilazione. Vietato estrarre dati sulle scelte politiche, religiose, sessuali degli utenti, vietato – facciamo sempre il caso di FaceBook – incrociare i dati con quelli di WhatsApp e Instagram. Vietato venderli a terzi, vietato inventarsi strani pop up che all’apertura di una pagina in rete ti chiedono se sei d’accordo all’utilizzo dei tuoi dati, con quaranta e più opzioni, tutte da spuntare. Secondo le nuove norme, la scelta dovrebbe avvenire con una domanda chiara, semplice, possibilmente con due sole risposte: sì o no.
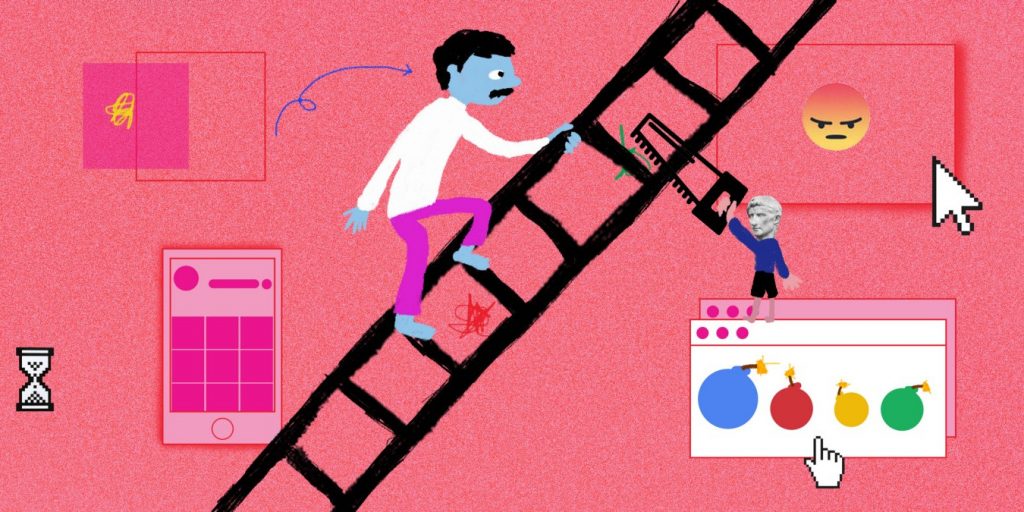
Fine di un modello?
Potrebbe essere la fine del modello di business delle piattaforme che sull’estrazione e sulla vendita dei dati, sulla sorveglianza dei comportamenti hanno costruito le proprie spaventose ricchezze. Ma è meglio usare il condizionale. Perché nella versione votata – oltre al sacrosanto divieto assoluto, non derogabile, di estrarre dati sui minorenni – c’è un articolo, il quinto. Articolo 5 che vieta tutto quello che abbiamo descritto, “salvo approvazione”. Tutto quello che è negato, insomma, può diventare possibile. Può esser permesso. Se si risponde sì alle domande dei “gatekeeper”, all’inizio della navigazione on line.
E così, per dirla con Malte Engeler – oggi giudice a Schleswig ma prima, per quattro anni, al lavoro in Europa alla protezione dei dati –, la soluzione dei problemi sociali, delle drammatiche storture di quei sistemi, viene spostata sull’individuo. Sulle persone, «sui singoli utenti, che sono i più deboli tra tutti i soggetti coinvolti». Lasciati da soli a decidere. Davanti a colossi che, è vero, non potrebbero impedir loro l’accesso ai servizi nel caso di rifiuto al trattamento dei dati, come è scritto nel testo.
Ma anche qui con un’eccezione: i “gatekeeper” potranno continuare a far quel che vogliono se è riconosciuto un loro “legittimo interesse”. Che non è spiegato nei dettagli. Che magari può tradursi in un: “ho bisogno dei tuoi dati per continuare a sviluppare” un’applicazione, un prodotto. Qualsiasi cosa. E quindi può essere adottato a piacimento.
Il modello di business insomma non verrà intaccato. Così come non verrà intaccato da quella generica affermazione sulla necessità di interoperabilità fra sistemi. Che, nelle intenzioni europee, per quel che riguarda gli utenti, si riduce alla portabilità dei propri dati, per altro già prevista dal Gdpr, il vecchio regolamento a difesa della privacy. A conti fatti, dunque, i “giardini recintati” di FaceBook, di Instagram, di Twitter, di Pinterest, di Snapchat e via dicendo resteranno tali. Rigidamente delimitati. E le persone potranno solo spostarsi da un social all’altro ma non potranno dialogare con quelli di altre piattaforme.
Dove invece le norme proprio non prevedono alcuna possibilità di scelta, è sugli algoritmi. E ora si parla del Digital Service Act. Poco prima del voto finale nell’aula del parlamento europeo, uno sparuto gruppo di deputati aveva presentato un emendamento. Con un testo che sembrava tecnico ma aveva un forte contenuto politico e innovativo: si stabiliva che l’utente, a cominciare dall’utente dei social, avrebbe potuto scegliere quale algoritmo preferire per la selezione dei contenuti suggeriti. Per capire meglio: si sarebbe potuto scegliere perché voglio che il social mi proponga notizie e avvisi sul rock e non sulla dance music, perché voglio informazioni sul Black Lives Matter e non su Trump. Emendamento bocciato, ovviamente, col solo voto favorevole della Sinistra Europea, dei verdi e di un po’ di socialdemocratici. Così, anche con questa “grande riforma”, alla fine, chi ti fornisce il servizio sarà l’unico a decidere cosa ti “conviene” leggere o ascoltare.
Non basta ad attenuare il carattere “rivoluzionario” delle norme, come vuole la vulgata? E allora c’è la proposta – sempre nel Dsa – che permette a uno stato europeo, a un governo europeo di chiedere la cancellazione di un contenuto on line. Cancellazione perché il file potrebbe violare il copyright, perché potrebbe essere offensivo, perché potrebbe «minacciare l’ordine sociale» (?). Così Orbán potrebbe chiedere l’eliminazione di un post o di un tweet scritto in Francia. Semplicemente perché non gli piace.
Anche in questo caso, c’è di più: perché le norme attribuiscono a diversi soggetti privati la possibilità di segnalare e ottenere immediatamente la cancellazione di un file se si ritiene che violi le leggi sul copyright. Soggetti privati: un eufemismo per definire le major cinematografiche e musicali. E le loro segnalazioni non avranno neanche bisogno di passare da un giudice, saranno “eseguibili” immediatamente.
Sovranismo digitale
Certo, da contrappeso, c’è l’esplicito rifiuto contenuto nel testo a utilizzare i filtri automatici. Quei filtri – gli upload filters – istruiti dall’intelligenza artificiale che controllano qualsiasi cosa scritta o pubblicata in rete e bloccano quel che ritengono sconveniente. Senza l’intervento umano. A parte il fatto che spesso questi meccanismi impongono la cancellazione di contenuti perfettamente legali, perché non sanno distinguere fra l’ironia, la critica e la violazione del copyright, i filtri automatici sono comunque uno strumento micidiale per tacitare il dissenso. Ovunque nel mondo, anche nel vecchio continente.
Ed è interessante a questo punto capire cosa accadrà con un’altra rilevante direttiva europea, quella sul copyright, varata ormai tre anni fa da Bruxelles e che sta per essere recepita da tutti i paesi (l’Italia l’ha già fatto, nell’estate scorsa). Perché, lì, nella direttiva, era appunto prevista la possibilità di utilizzare i filtri come extrema ratio per difendere i titolari dei “diritti riservati”. Ora invece quello strumento tecnico viene escluso. Difficile dire cosa succederà.
Il riferimento a quel che è avvenuto con l’approvazione della direttiva sul copyright in ogni caso non è sbagliato. Perché allora, i più attenti analisti, come Benedetto Vecchi (anche in quel caso davanti a una platea di sostenitori entusiasti, platea che comprendeva pure il sindacato dei giornalisti italiani) sottolinearono che lo scontro che precedette il suo varo non era una battaglia fra “nuovo e vecchio”, come tanti sostenevano. Era semplicemente uno scontro fra i nuovi monopolisti della rete e i vecchi monopolisti dell’editoria.

A ben guardare, Dma e Dsa raccontano una storia simile. Raccontano di norme progettate solo a partire dal mercato, dove contano solo le imprese. E dove fra due interessi contrapposti – capitale statunitense e capitale europeo – si sceglie di tutelarne uno. In quell’”uno” però non ci sono gli utenti. Perché si sceglie di attenuare il peso dei gruppi americani, prevedendo che le leggi si applichino ai colossi che hanno 45 milioni di utenti mensili e un fatturato di almeno 6,5 miliardi annui. Soglia che invece, per dirne solo una, terrebbe fuori – se non verrà cambiato nulla – “booking.com”, il gigante olandese delle prenotazioni on line.
Norme che sembrano, insomma, riguardare “loro”, la difesa di un’ipotetica nuova economia europea (è questo quel che intendono per sovranismo digitale?), la difesa delle imprese made in Europe, finora soccombenti nella competizione internazionale.
I diritti, i diritti digitali delle persone restano un po’ ai margini, più raccontati che reali. E se è così, l’entusiasmo delle associazioni “di base” – davvero tutte, da Eff ad Edri passando per AccessNow – sembra davvero un po’ fuori luogo: parlano di “successo della società civile”, capace di piegare le Big Tech, anche se restano rischi che le lobby pesino sulle scelte finali. Frase che forse può essere semplicemente ribaltata: norme fatte per e dal mercato, per un nuovo mercato, che le opinioni pubbliche sono riuscite, in parte, a mitigare.
Opinione pubblica, comunque, non la politica. Perché uno degli elementi più rilevanti di questa vicenda è l’assoluta mancanza di un movimento che rivendicasse una nuova cittadinanza per i diritti digitali. Ormai inseparabili da tutti gli altri diritti. Rivendicasse con lotte, con presenze, testimonianze. Come pure è avvenuto in altre stagioni. Non in Italia ma altrove è avvenuto. Stavolta no, invece. Solo qualche comunicato nei passaggi chiave e un po’ di petizioni. Il risultato è, appunto, quel Dma e quel Dsa. A ricordarci, una volta di più, che le raccolte di firme da sole possono cambiare due righe di un testo, non la sostanza.
Tutte le immagini da commons.wikimedia.org
