cult
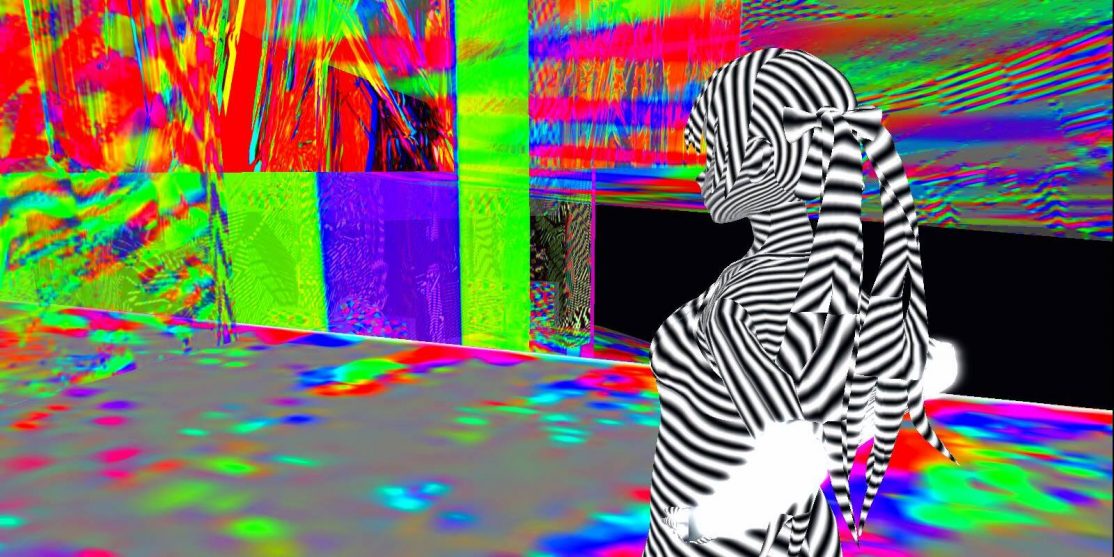
CULT
Niente di meno
Esce per la prima volta in traduzione italiana per la LUISS University Press un lavoro di Sadie Plant, fondatrice dello storico Cybernetic Culture Research Unit. In “Zero, uno. Donne digitali e tecnocultura” del 1997, Plant riflette sul potenziale di liberazione femminista della rivoluzione digitale
Uno. Linea dritta, asta eretta, lancia o osso aguzzo attorno a cui la mano dell’Uomo si avvolge e impugna. Forma, arma, fallo.
Zero. Carne in cui il bastone affonda, la picca lacera, carne che si apre, si rompe, respinge o accoglie. Materia, vuoto, vulva.
Zero, Uno: pittografia, mitografia, storiografia dell’Uomo, dell’identico – Uno –, che sempre ritrova, al fondo di ogni altr* essere, se stesso. Dell’Uomo e del suo progresso, ascesa e accumulazione, spinta accelerata ma invariante – l’uno elevato a potenza: scagliato roteante in progresso, eretto ad aruspice del futuro, lanciato roboante nello spazio, sempre uno rimane. Storia dell’Eroe, come sostiene Ursula Le Guin: «Prima che tu te ne accorga, le abilità de* costruttor*, i pensieri de* pensator*, le canzoni de* cantant* sono tutti parte di essa, sono stati messi a servizio del racconto dell’Eroe. Non è la loro storia: è la sua». Storia in cui le donne, come (gli) strumenti, come (gli) attrezzi e come (le) macchine, non sono che infrastruttura, accumulazione originaria, plusvalore, merce, materia prima o manodopera – di seconda mano, oltre che di secondo sesso.
Uno più zero, ricorda Sadie Plant in Zero, Uno. Donne digitali e tecnocultura (Luiss University Press, 2021, ed. or. 1997), echeggiando Luce Irigaray, fa sempre uno:
Maschio e femmina sommati fanno un uomo. L’equivalente femminile non esiste. […] La donna “funziona […] come un buco”, un intervallo, uno spazio, “un niente – di medesimo, d’identico, d’identificabile […] una falla, un difetto, una mancanza […] fuori, rispetto al sistema di rappresentazioni, o di autorappresentazioni, dell’uomo (p. 75).
Perché la donna raccoglie cibo e prepara da mangiare, porta in grembo la prole e tramanda geni. Riproduce. Reduplica. Segue le istruzioni, lasciando che l’uno si moltiplichi per se stesso (anche se, malgré tout, non da se stesso). Tecnologia riproduttiva, macchina per le addizioni: nota di commento a piè di pagina, in cui il testo principe non ha intenzione di sfrangiarsi e slabbrarsi – voce che solo rinforza la parola autoriale, di cui la parola autoriale si fa forte, da cui si eleva. Le donne sarebbero sempre state «in grado solo di replicare materiale identico, mentre gli uomini si dedicavano a cambiare il mondo» (p. 151).
Le donne «non hanno interiorità», scriveva Nietzsche in Umano, troppo umano (§ 405), «sono pure maschere. È da compiangere l’uomo che ha a che fare con tali esseri quasi spettrali». Sono sola parodia e riproduzione le donne – anzi, proprio le femmine – negli animali umani e non: del sauro Hemidactylus stejnegeri non si ritrova alcun esemplare maschio, perché gli individui femminili si moltiplicano per partenogenesi, l’un l’altra mettendo in moto i rispondenti processi chimici attraverso un’imitazione degli atteggiamenti sessuali del maschio. Interpretazione, mim/azione, auto-fecondazione. Il circuito si chiude. Le donne sono pura apparenza o pura inconsistenza, sola esteriorità, sola mimesi senza neppure l’intenzione della mimesi: imitazione dell’Uno e, quindi, meccanica e materica.
Il destino delle donne è allora legato a doppio filo (seppur entramb* chius* a doppia mandata) a quello degli automi, dei replicanti, dei cyborg, di tutto ciò che non avrebbe essenza propria in quanto sola funzione: il femminile è una diffusa macchina di Turing, o la macchina di Turing è femminea nella sua capacità
di simulare il comportamento di qualsiasi altra macchina, perfino di sé stessa. Esiste davvero solo nel momento in cui ha uno specifico compito da portare a termine, e a quel punto non è più se stessa, ma semplicemente ciò che sta facendo. Può fare, ma non può essere, qualsiasi cosa (p. 126).
Sarà per questo che queste due virtualità, autentiche macchine desideranti, si intrecciano assieme in potente feedback positivo. Trama e ordito dell’arazzo intessuto da Aracne-Ada Lovelace-Sadie Plant, che incastra e muove i pedali del telaio – quel telaio di Jacquard, macchina a schede perforate, prototipo di ogni calcolatore, e quel telaio a cui è relegata ogni femmina, individuo senza arte né parte – se non, appunto, quella del filato.
Il telaio, dunque. Che sta all’inizio – poiché, come detto, prodromo e progenitrice di ogni altra macchina a venire – e al contempo alla fine. Perché, in qualche modo, il telaio funziona a rovescio: il complicato e rifinito disegno che verrà poi riprodotto (diacronia) dal movimento di leve e spole è infatti già deciso e organizzato in partenza (sincronia) – il suo schema ornamentale è contenuto in forma di codice (zero, uno: presenza o assenza di fori nella placca di metallo o di cartone), e perciò è, e sussiste,in anticipo sulla sua effettiva materializzazione. È informazione e pregressa memoria che congiunge passato e futuro, vincolando quest’ultimo a proprio vantaggio, modulandolo a proprio piacere – il sistema di schede perforate spiega ai meccanismi come muovere: eppure è anche vero che il pattern si crea, e si modifica, mentre la macchina è coinvolta, e si distrae, nel più lungo e disteso movimento.
Così, per esempio, in ogni fabbrica tessile si intrecciano, oltre che le fibre e i fili, anche le fila, i racconti e le visioni delle lavoratrici all’opera – tessuto di biografie, che si fa intricato garbuglio e rizomatico nodo, e disturbante accavallamento, capace di dirottare perciò la storia – che l’Uno vorrebbe già scritta e una – verso in/finite, interminabili storie. Ecco il potente moltiplicarsi di società parallele a quella dell’Uno, forse segrete e talvolta ctonie: si parla in codice, si criptano le voci per renderle immuni alla scrittura immediatamente decifrabile e derubricabile.
Aggiriamoci, allora, nei pressi dell’inizio e della fine: il testo di Plant si colloca nella seconda metà degli anni ’90, nel mezzo di un intenso fermento tecnologico e digitale. Forse a questa situazione e posizionamento è imputabile un certo ottimismo, un certo tono entusiasta e/o profetico che ne agita le pagine – l’attesa fiduciosa del veder (infine) conclusa, e non più risanabile, l’insorgente (in/formazione) spinta in orizzontale. Che è rappresentata dai computer come potenzialità inesausta da un lato (quale rete globale, mappa in costante ridefinizione e movimento, in cui la periferia contesta e divora e infesta il centro) e dall’industria del tech nella sua materialità tangibile dall’altro (quale sistema di produzione che si appoggia, più di ogni altro, sul lavoro femminile, e che determina perciò «un cambiamento radicale nello status delle lavoratrici» e «l’erosione del monopolio maschile su determinate mansioni» (p. 80). Il cosiddetto grenderquake, che si sarebbe dovuto sperimentare a più altezze da quasi ogni nazione):
I computer avrebbero dovuto costituire uno strumento infallibile per perseguire i soliti scopi: previdenza sociale, organizzazione politica, ordine economico, previsione e controllo […]. Ma perfino al livello più elementare, questo campo teoricamente dominato dalla logica, pilotato e controllato, si rivelò fin dall’inizio altamente imprevedibile (p. 73).
Destinazione decisa già in partenza, e ruolo nella storia già previsto sin dagli albori (del femminile, della macchina: delle virtualità) – ecco però un errore nell’intreccio, un intrigo nell’intrico, un bug o un worm, un’imprevista e latente macchinazione. La rete non irreggimenta e non apporta ordine, non cataloga e non censisce, come le è stato in origine chiesto. Non riproduce (più) l’Uno, ma se stessa, e gli errori che ospita: non intrappola e incastra chi ci si avventura e chi ci si impiglia, come auspicato dall’alto, ma vive piuttosto dei suoi stessi buchi, si espande e si gonfia, si diffonde a macchia d’olio. Il campo si rivela altamente imprevedibile. Eppure – ulteriore turn della trama, giro di vite e strettoia nel labirinto, il mondo brulicante di Zero, Uno vede presto la sua maglia di nuovo stretta nella presa asfittica del capitale: quel che era sparso e forse disperso viene lentamente ri-adunato (l’indocile è riportato all’ovile, il suo percorso recintato e reso stereotipico). Come giustamente illustra il Gruppo di Ricerca Ippolita,
quando Sadie Plant nel 1997 dà vita a Zero, Uno. Donne digitali e tecnocultura, l’oligopolio dei GAFAM non è nemmeno all’orizzonte. La rete era un proliferare di esperienze disordinate, il web era appena nato e nessuno sembrava porsi l’idea che il suo disciplinamento tecnico avrebbe coinciso con un regime mondiale di disciplinamento e gestione produttiva della biodiversità umana (p. 31).
Partiamo, dunque, dall’inizio e dalla fine, riepiloghiamo il viluppo di intoppi: sì, il mondo postbellico immaginava per se stesso la tutela di regolamentazioni e severo controllo – il computer sarebbe stato il principale attore militare di questa operazione, se non, in aggiunta, anche carceriere. Eppure – e qui si colloca il sollievo, e la speranza, di Plant – la prevista e imposta monodirezionalità è stata presto confusa e stravolta dal computer stesso (dal digitale come luogo di infinite connessioni e scambi, impossibili da registrare e pilotare in anticipo). E sì – sottolinea Ippolita – forse ancora oggi il movimento si inverte, e il web diventa portainnesto di nuove accumulazioni e centralizzazioni. Eppure (ancora, da capo, svolgendo le fila, ordito rivoluzionario) si può seguitare a disegnare il tessuto dalla fine, come fa da tempo immemore ogni tessitrice seduta al telaio, e come probabilmente ha fatto anche Plant tracciando le linee – contro corrente – di una rete sconnessa e vitale, proprio perché dis/organica. E dunque non sospirare per l’ostruzione in itinere, ma cospirare per l’epilogo sperato, e affidato (sin dall’inizio) in istruzione alla macchina, all’animale, alla donna: avendo fiducia che tutt* si uniscano in lotta. Risulta infatti presto chiaro che anche Zero, Uno, come le sue protagoniste e comparse e controfigure e muse, si avvale della tecnica propria di tutte le macchine desideranti che questa favola intessono:
Si tratta di isteresi, il ritardo degli effetti sulle proprie cause. Reverse engineering. Il modo in cui gli hacker e i pirati cospirano per attirare il futuro dalla loro parte. Partire dalla fine, e poi intraprendere un processo che allo stesso tempo assembla e smantella la strada proseguendo all’indietro, fino all’origine, alla fine, al futuro, al passato: ormai cosa importa? (p. 67).
Zero, uno. Non è di seconda importanza sapere quali desideri e quali mani intreccino i fili del destino e le fila del discorso e le fibre della stoffa: nella tecnica del tessile, la matrice (la materia, il filato o lo spago o il cavo) compongono l’immagine risultante in modo letterale. Il disegno è il processo che produce la forma, la forma è il substrato, non si aggiunge in seconda battuta. E così lo stesso testo di Plant è un tessuto, composto di inserti (le citazioni in grassetto, che interrompono e irrompono nel discorso: zero, uno) e di fili sottili sparsi tra le sue stesse parole, tanto che è quasi impossibile citarla senza citare chi cita, e venire a capo del corpo del testo e del suo piede (di pagina) – sbrogliare la matassa, individuarne il cuore e il rocchetto.
Così Plant, e così Zero, Uno, è Ada Lovelace e ANNAFREUD, è ancora Mary Shelley, è ancora il ragno e la sua seta e le sue uova, o la falena che si annida nei circuiti – o Grace Hopper, che omaggiando il lepidottero pirata introduce nel lessico informatico il termine “bug”. E tutti gli insetti nascosti nei centralini, che sommano alle voci in transito il loro invertebrato brusio, e ancora tutte le donne e l* bambin* senza volto – «proletariato del proletariato, come le ha definite Engels»:
Immerse in microprocessi di basso rango della produzione tessile, in lavori di segreteria e nella produzione di componenti minuti, le donne sono i più anonimi e insignificanti ingranaggi della macchina industriale (p. 118).
Tutto quel mondo di agenti, al di sotto dei padroni, che però fra loro interagiscono, e, assieme (intessut*) si oppongono al passaggio di corrente (resistenza) e del corrente messaggio e/o ordine. In questa intra-azione e letterale entanglement si crea sempre di nuovo quella «diagonale che sembra tagliare e superare le coppie binarie di uno e altro, padrone e schiavo» (p. 123). Di uomo e donna, di Uomo e Animale, se l’operazione del filare ogni rete – tragica ironia della sorte – pesca anche dall’arte perfezionata da uccelli e aracnidi nei loro stretti nidi, o si lega e aderisce alla conformazione delle piante che il tessuto compongono (conformazione naturalculturale: dipende e dalla trama della foglia, dalla sua crescita e dalle sue vegetali vicissitudini, e dal modo in cui è stata fatta essiccare sotto il sole).
E quindi, ancora dall’inizio: dal primo uovo di ragno, dal primo guscio del baco da seta, dal primo filato, dalla prima net che dalla macchinazione dei due fili (verticale e orizzontale, zeri e uno) si struttura, dalla prima trama. Consapevoli, però, che «la sola idea che una cosa venga “prima” è una frottola che serve a occultare le continuità non lineari, per le quali il concetto di “punto d’origine” è una blasfemia» (p. 274). Ripartire allora non dall’origine ma da un loop, circuito ciclico e senza fondo in cui zero e uno e femminile e maschile e umano e nonumano si mordono la coda (e mordono il capo). Dall’avanti all’indietro (e viceversa), dal sopra al sotto (e viceversa), dal dentro al fuori (e viceversa), movimento ricorsivo che, ancora (!), è quello del filare. Gli originari e più basilari «microprocessi» delle tessitrici, del resto,
sono alla base di tutto: il fuso e la ruota utilizzati per filare sono il punto di partenza per tutti i perni, ruote e le rotazioni future; dai fili intrecciati del telaio derivano i più astratti processi di fabbricazione I processi tessili sono, in senso molto letterale, il software di tutta la tecnologia (p. 103).
Non è dalla fibra più o meno lasca della sporta, della carrier bag, dalla sacca che è rete per contenere e trasportare viveri (e ad altr* distribuirli: accumulazione, poi spartizione) che la tessitrice di Le Guin pretendeva di inventare, dal margine del mondo, una nuova storia? «Il primo dispositivo culturale fu probabilmente un recipiente», sostiene anche Elizabeth Fisher in Women’s Creation. Un capiente intreccio di cordame, ipotizza Plant. Qualcosa a partire dal quale creare una piega, un’involuzione, un di meno, che è un di più, di realtà – fosse pure malfunzionamento. Qualcosa a partire dalla quale fare una differenza. Ecco lo zero (o meglio, gli zeri), più (gli) uno, di cui consiste il digitale: in cui lo zero non è, come a lungo è stato considerato, «nulla, ossia il simbolo del niente, dato che da solo non ha nessun valore» (p. 93). In cui gli zeri non semplicemente aggiungono valore, regalando decine, centinaia, all’unità: digitale in cui zeri e unità piuttosto si uniscono i gruppi, per contenere, e assieme aprire a, nuove dimensioni. «Digitale rimanda alle cifre della matematica piene di potenziale che, come previsto, si assemblano in gruppi di otto invece che in coppie binarie» (p. 90).
Ecco allora la macchina come più sofisticato strumento che raccoglie informazioni da ciò che le è esterno, e le rende utilizzabili per il proprio funzionamento, distribuibili lungo il proprio corpo e lungo altri corpi. La rete che ha ingerito così tanto dell’organico da poterlo mimare alla perfezione (a proposito di organico e inorganico, e tessuti imprevisti: la seta del ragno meta menardi era ritenuta la sostanza biologica più resistente fin quando il “primato” è stato scalzato dalla radula, ossia la lingua dentata, del genere patella. Dalla vulva bivalve del mollusco si allunga un organo capace di inglobare nella propria matrice, fatta di chitina, la ferridrite degli scogli, che viene cristallizzata nel giro di poche ore in goethite: biomineralizzazione che regala a questo ibrido una resistenza maggiore della più potente fibra artificiale). Dentro, fuori: rinunciando però al desiderio di distanza e di separazione, al binarismo schematico di zero e uno e interno ed esterno. All’imperativo di immunità e protezione che per Freud informa e ogni esoscheletro e ogni suo varco, sia esso antenna o occhio o generale organo di senso (e che per Canetti informa invece il bastone, arma originaria perché più naturale, nella sua primaria funzione di tener lontano, mantener estraneo e fuori). Ecco allora la cibernetica, che trascende il determinismo della causalità lineare e dell’altrettanto lineare temporalità (cominciamo dalla fine che è ancora l’inizio, dall’inizio che è già la fine…). Ecco la carrier bag di lasco filo intessuta, buco (e dunque alternativa, e dunque via di fuga) alla freccia del tempo, al tempo delle frecce e delle lance e delle clave, tecnologie di dominazione e di potere verticale ed erettile, anziché organizzazione decentralizzata e diffusa. Ecco allora la tecnologia come bagaglio. Ed ecco questo bagaglio, concavità e ventre, continuamente rivoltato da questa «fabula speculativa per schiavə in rivolta» (splendida definizione del libro data da Ippolita in apertura, p. 35).
«Nel 1933, Sigmund Freud fece un ultimo tentativo di risolvere l’enigma della femminilità […]. “Si dice che le donne”, scrisse, “abbiano fornito pochi contributi alle scoperte e alle invenzioni della storia della civiltà”» (p. 65). Eccesso di fedeltà, le donne, come (le) macchine, non introdurrebbero modifica né sorpresa né novità nel reale, che sarebbe invece continuamente plasmato (reso più umano e civilizzato) dagli uomini come attori, come eroi. Alle donne solo lo spazio (concesso) per la continua addizione e la continua riproduzione. Lo zero per cui passa, intoccato (a distanza) ma nuovo, ogni uno. «“Eppure c’è una tecnica che esse hanno inventato: quella dell’intrecciare e del tessere”» (sempre Freud citato da Plant, p. 65). Una tecnica la cui meccanicità e la ripetizione irriflessa – una tecnica che manca di riflessione, di autonomo pensiero, che, dunque, solo specchia e duplica: sovrabbondanza lapalissiana – ben si sposa con l’indole femminile.
Parliamo ancora delle donne, parliamo ancora delle macchine, o della acefala e tipizzata tecnica animale, quando diciamo che queste «possono portare a termine soltanto ciò che sono state istruite a fare» – «se fanno qualcosa di diverso dalle istruzioni ricevute, hanno perciò stesso fatto qualche errore» (così un ironico Turing citato da Plant, p. 140). Siamo sicur*, allora, ci domanda Plant, di essere davvero capac* di distinguere l’errore dal rifiuto di portare a termine le istruzioni impartire e comandate? Dal rigetto della compostezza, del decoro, del rispetto? Sbagliare non è forse già sabotare – ripudiare il duplicare, l’allungare, l’innalzare, il cementare e l’irrobustire, l’ordine? La Macchina Analitica di Ada Lovelace non è forse, più che prosecuzione, manomissione e rivoluzione, della Macchina Differenziale di Babbage?
«Quel che Freud ha scambiato per mancanza di civiltà nella donna è in realtà mancanza di fedeltà alla civiltà nella donna», scriveva Lillian Smith. E così per la macchina sua replicante che lei replica in una rizomatica scena interminabile. Esiste il caso (digitale) in cui la somma di zeri e di uno dia qualcosa di diverso da zero più uno: esiste la riproduzione del codice errata, virale, che si inietta nel, e altera, il corpo conforme – e lo invita a percorrere altre vie, forse dello sbaglio o forse della scoperta (ma che importa ormai distinguere sbaglio da scoperta? Quel che di nuovo spunta, di nuovo, dal tessuto?). Il gioco è qui quello di non farsi scoprire: rimanere latenti, imitare il medesimo per non destarne né gli avversi sospetti né le morbose attenzioni. Plant cita così Deleuze e Guattari: «Più si schizofrenizza, meglio funziona». E prosegue «E per sistemi come i replicanti ribelli, l’identità è facile da simulare: è solo uno dei tanti programmi da far girare» (p. 140). A vuoto. E nel vuoto che abbiamo scavato e che rivendichiamo, tessendolo e facendoci tessere.
