cult

CULT
Antonio Gramsci, I quaderni del carcere
Si può dire che i Quaderni del carcere di Gramsci sono un testo leninista? O leniniano? Le allusioni al capo bolscevico sono sparse dappertutto, sempre – per evidenti ragioni di prudenza carceraria – in forma criptica: nell’ottobre 1930 «Iliíč», dall’ottobre-novembre dello stesso anno fino al maggio 1932 «Ilici» ma anche «Vilici», nel 1932 «il più grande teorico moderno della filosofia della praxis». La prudenza era però non solo carceraria: Gramsci sapeva che, dopo la furibonda lotta del 1924-26 per l’eredità di Lenin e per la formulazione della versione vincente del “marxismo-leninismo”, gli spazi per un approccio ingenuo era del tutto consumati. È vero che mai il suo modo di leggere l’azione del capo bolscevico era stato da “intellettuale” (penso al libretto, del resto importantissimo, di Lukács del 1924), ma sempre e solo da politico: fin dai primi articoli torinesi fino al fondamentale «Capo» del 1924, nel mutare delle circostanze e dei riferimenti, l’Ottobre, i bolscevichi, Lenin erano “tradotti” in lingua italiana, in termini politici immediatamente utilizzabili da parte di una forza politica ben determinata: il Partito Socialista prima, Comunista poi, per l’elaborazione di una strategia adatta all’Italia. Ma appunto la ripresa di questo lavorio alla fine degli anni Venti accade in una situazione assai differente, nella quale non solamente l’approccio non era né poteva essere ingenuo, ma che imponeva una circonferenza netta al tipo di letture possibili.
Quanto precede sia detto per marcare il fatto che, accanto alla persistenza di un approccio nettamente politico – il punto di vista del prigioniero rimane sempre quello del PCd’I, per il quale, dentro il quale e a partire dal quale ogni passaggio dei Quaderni è scritto – emerge ora un chiaro tentativo di ricavare dentro la Komintern gli spazi per una dialettica di discussione teorica che fosse direttamente funzionale a una reale articolazione politica di quel complesso organismo. È un approccio molto originale, possibile, in questi termini, dall’interno del carcere e che per questa ragione poté costituire la base per la politica comunista successiva alla Liberazione. Ma questa constatazione di fatto non può scadere in una teleologia, per quanto eterogenetica. I Quaderni vanno letti nel loro presente, come una proposta di innovazione teorica e politica dentro la Komintern e dentro il PCd’I.
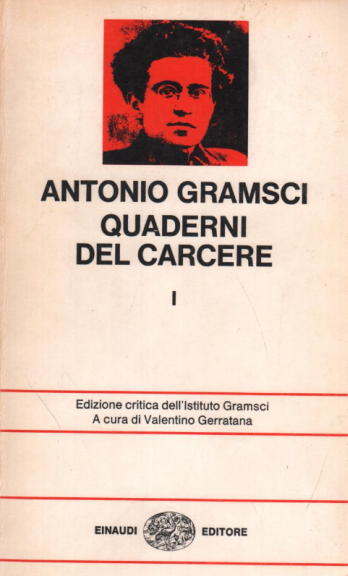
In questo senso, è significativo che il Lenin che in essi compare si possa ridurre a due grandi tipi. Anzitutto, l’inventore dell’egemonia, intesa come fatto e come concetto: «avendo fatto progredire la dottrina politica avrebbe fatto progredire anche la filosofia»; in ciò sta «l’apporto massimo di Iliíč alla filosofia marxista, al materialismo storico, apporto originale e creatore»1. E nella seconda stesura: «Ilici avrebbe fatto progredire effettivamente la filosofia come filosofia in quanto fece progredire la dottrina e la pratica politica. La realizzazione di un apparato egemonico, in quanto crea un nuovo terreno ideologico, determina una riforma delle coscienze e dei metodi di conoscenza, è un fatto di conoscenza, un fatto filosofico»2. Il Lenin qui in questione non è il polemista socialdemocratico, ma il dirigente politico. Più precisamente, è il Lenin che, senza più preoccuparsi dell’ortodossia, sperimenta dopo il 1921 i modi di costruzione del socialismo, esaltando il ruolo della “direzione”, dell’equilibrio tra città e campagna, come unica via per la conquista di un appoggio di massa, senza il quale ogni sforzo di socializzazione rimarrebbe vano. Ma, osserva Gramsci, impegnandosi per costruire un «apparato egemonico» Lenin realizza anche un salto sul terreno teorico, filosofico, «metafisico»3, perché presuppone che l’ideologia sia una solida realtà, non un’illusione, e che vi sia una corrispondenza piena tra economia, politica e filosofia (cultura). Di qui la necessità implicita di una filosofia della praxis, come esplicitazione di questo “salto”.
Ma accanto a questo Lenin c’è il teorizzatore della traducibilità dei linguaggi: «Nel 1921: questioni di organizzazione. Vilici disse e scrisse: “non abbiamo saputo ‘tradurre’ nelle lingue ‘europee’ la nostra lingua”»4. Il riferimento è al 1922, non al 1921, cioè al IV Congresso dell’Internazionale, quando Lenin aveva lamentato che le risoluzioni erano scritte «in russo», anche se tradotte in molte lingue. Questa raccomandazione è collocata da Gramsci al centro dell’idea di traducibilità dei linguaggi, che a sua volta è il nucleo della filosofia della praxis. L’articolazione territoriale orizzontale in base ai linguaggi nazionali e quella verticale tra filosofia, politica ed economia sono correlate, e si alimentano reciprocamente: la tesaurizzazione dell’esperienza sovietica va fatta sulla base di un ripensamento, che ha a suo punto di partenza proprio il ripensamento di Lenin in relazione alla funzione delle ideologie nel processo di costruzione di una politica di tipo nuovo.
Gramsci sapeva che questo Lenin era al limite dell’accettabilità, ma pensava di avere sufficiente autorità per poter portare avanti, una volta uscito dal carcere, il suo progetto di rinnovamento del campo comunista. Le idee che ho esposto risalgono però a un periodo compreso tra il 1929 e il 1932, prima del nazismo e della guerra in Etiopia e in Spagna. Gramsci morì il giorno successivo al bombardamento di Gernika, dentro uno scenario in gran parte nuovo.
1 A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, p. 465.
2 Ivi, p. 1250.
3 Ivi, p. 886.
4 Ivi, p. 854.
